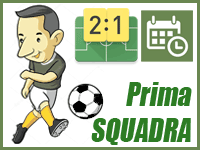Il calcio sulla “piazza granda” di Telve negli anni ’40 nei ricordi di Marco Fedele
“…Poi toccò finalmente a noi; finalmente ne divenimmo padroni (della “piazza granda” ndr) e fu tutto un altro gioco.
Sì, perché noi, poveracci, avevamo un pallone “Pettinelli”; dico, un pallone di cuoio da calcio cucito a mano che arrivava nientepopodimeno che da Venezia, Mercerie di Rialto, nuovo di zecca, con le “stringhe” a far da chiusura, che quando ti colpivano ti staccavano la testa; dalla camera d’aria rossa con il bocchino a far “ciucioto”, che richiedeva esperienza e tocco lesto a gonfiare, legare, cacciare dentro e fuori, a stringere e domare corde, spaghi e … angoscie inquiete e calde. Anche in questo avevamo i nostri specialisti, svelti di mani e di polso, sempre troppo lenti nell’incombenza. Ci era costato sacrifici e rinunce quel pallone, un intero inverno di risparmi, di “musine”, 5 centesimi alla volta, di spiate lunghe e sotterfugi illeciti, di occhiatine nel taccuino di casa, di “arrangiamenti” forse tollerati, ma mai confessati. A quei due studentelli, l’uno a Venezia l’altro a Telve, amici-cugini per la pelle che la passione del pallone e la voglia matta di una “pipata” (rubata) in santa pace univano indissolubilmente (e birbantemente) nel peridoo estivo del cosiddetto riposo fisico e mentale, quel pallone tanto desiderato era costato un mondo. Però la “anonima società” aveva funzionato per davvero.
(…)
Fatto sì è che quel benedetto pallone fece il suo ingresso trionfale nella piazza Maggiore di Telve, ammirato, toccato, venerato, custodito, poi preso a calci da un subbuglio di ragazzotti, patrimoni odi tutti e di nessuno, conservato da un’estate all’altra almeno per un quinquennio intero. Miracoli del saper fare e del saper durare dell’epoca, del grasso e della cotica e dell’arte calzaturiera della famiglia Doro Fedele di Pietro di Doro di piazza Maggiore! E fu per davvero, per un’intera generazione, il divertimento del sabato sera e della domenica dopo “dottrina”; guerra o non guerra, coscritti o non coscritti, a pancia piena o vuota com’era all’epoca costume (ognuno aveva una tessera eduna razione di “trisa” al giorno), sicuramente a tasche stabilmente vuote e a … piedi undi o quasi. Già, perché quei disperati sapevano anche giocare (?) al calcio in quella piazza con quello che avevano: un paio di scarponi militari (quel bendiDio seminato “con generosità” nel paese nel ’39 dal battaglione di fanti “tal dei tali” in parteneza per la Grecia) o le “drambe” del Campestrin o fatte dal nonno con pazienza tutta contadina nei riposi autunnali di Musiera.
La squadra? La maglia, il nome, i ruoli? Un arbitro? Beh, ora si esagera o si è duri di comprendonio: qui non ci sono tattiche e regole, metodo o sistema, non esiste traccia né di allenatore, né dell’esimio presidente; si gioca, si calcia, si corre tutti dietro a quel pallone che ha il vizietto di saltellare di qua e di là senza coscienza, e si cerca, così per caso, di cacciarlo dentro a una finta porta segnata con due sassi alle estremità della nostra piazza Maggiore, in barba ad un portiere che non aveva proprio voglia di finire sulla cruda terra della piazza. Sì, perché la nostra banda aveva anche un portiere di tutta fiducia: Rino Grendene, che aveva avuto la malasorte di averci rimesso un ginocchio malcurato; per cui poteva giocare, sì, ma solo quale portiere “titolare”. E per giunta riusciva a cavarsela meravigliosamente bene. Davanti al portiere, Ezio D’Aquilio, il geometra, spilungone e sempre ordinato, faceva il terzino “alla Rosetta”; però come secondo baluardo c’era Doro de Piero de Doro che troveremo a tirar campane e orecchie agli scolari di Castelnuovo: si metteva per traverso contando sulla potenza rude del fisico, e nessuno passava più. O palla o gamba, ed ecco la difesa schierata e pronta alla battaglia, scegliere di brutto, come avrebbe insegnato a quei tempi ciabattoni il signor Rocco a quelli del Padova club. Meglio, molto meglio, conservare la sanità del corpo…e la gamba. Quando si è scarsi di tecnica, vale la pena metterci un po’, solo un pochettino, di “porcheria”.
Poi al centro, “mediano di spinta”, dai lanci “profondi” dieci metri, solo soletto, un mingherlino, leggerino ma veloce, “nostrano-foresto” che per nove mesi all’anno se ne stava buono a “slambrotar” greco e latino e gli altri a sputare sangue su e giù per Restena e così, per passatempo, a fare il fiato dietro a un pallone capriccioso.
Ai lati, Luciano dei Cassiani, che aveva l’ingrato compito di correre lungo Paterno, dove il pallone non arrivava mai per l’inclinazione del terreno e finiva sempre per l’andare dove non doveva andare.
A sinistra un secondo a far da ala, un certo Rani della Sega, anch’egli mezzo telvato, ora pure mezzo musieroto, che ci sapeva fare lungo il muro dell’orto, attento che l’oggetto prezioso di cotanta contesa non finisse sui cavoli e la salata dell’Imeni.
Gli altri non contavano, era loro permesso giocare solo perché c’erano e bisognava far due squadre, e non era lecito, per colleganza, così sui due piedi, rimandarli a casa a far la calza: fin che c’era fisico, tutti per uno e uno per tutti, tutti a spintonarsi in cerca di un pallone che non si trovava mai nemmeno sulla punta di scarpone. Era gol, non era gol? A forza di grida, di spintoni, di proteste o di confewrme vigorose ci si metteva d’accordo.
Il numero dei giocatori? Altro quesito senza regola e risposta: non si operavano esclusioni, limitazioni o assegnazioni di posizione, uno più o uno meno non faceva troppa differenza: meglio “abundare quam deficere” poiché, a parer nostro, valeva la bravura, non certo il numero dei contendenti. La “squadra” era di sei, tanto consentiva il campo comunale, intendiamoci la base, poi per il resto provvedeva la Provvidenza. Naturalmente c’erano dei privilegiati, come in tutte le società che si rispettino, inamovibili, prediletti coccolati, contesi, desiderati negli schieramenti opposti: la difesa, per esempio, ormai codificata e rotta ad ogni prova, era assegnata stabilmente ai tre veterani di ogni battaglia, agli antesignani del gioco, amici per la pelle e nelle chiacchierate: Doro, Ezio, Marco. Così si giocava, squadra contro squadra, nella piazza Maggiore di Telve nei tempi eroici, per ore intere, gridando, “os-ciando”, “sacranonando”, rompendo timpani ed altro, con le segnature del combattimento sulle ginocchia e le “rosegaure” ai piedi portate, indicate come medaglie al valore ed esibite come trofei. Già, perché non ci si limitava a battagliare fra noi, così alla buona fra amici, ma si cercavano affermazioni gloriose perfino oltre confini, oltre vallata, oltre il chiuso paesano, ricorrendo all’aiuto veicolare del camioncino scarso di freni di Mario Gianesini. E allora andavano di mezzo l’onore e la dignità del paese. Ed era battaglia. Roba in grande, eroica, superiore alla forza reale e alal capacità gladiatoria degli attori. Ma le botte son sempre botte e il disonore sempre infamante.
Però…però, bisogna pur dire che questi quattro matti, eternamente arrabbiati dietro un pallone che perdeva el pezze e tutto il resto, pur essi fatti di pezze e di roba ritinta e riciclata, riuscivano perfino, con impegno e dedizione, a convogliare l’attenzione paesana ed i commenti, non tropop gentili in verità, dell’elemento femminile, interessato più ad altre mete che all’effettivo svolgimento della tenzone.
(…)